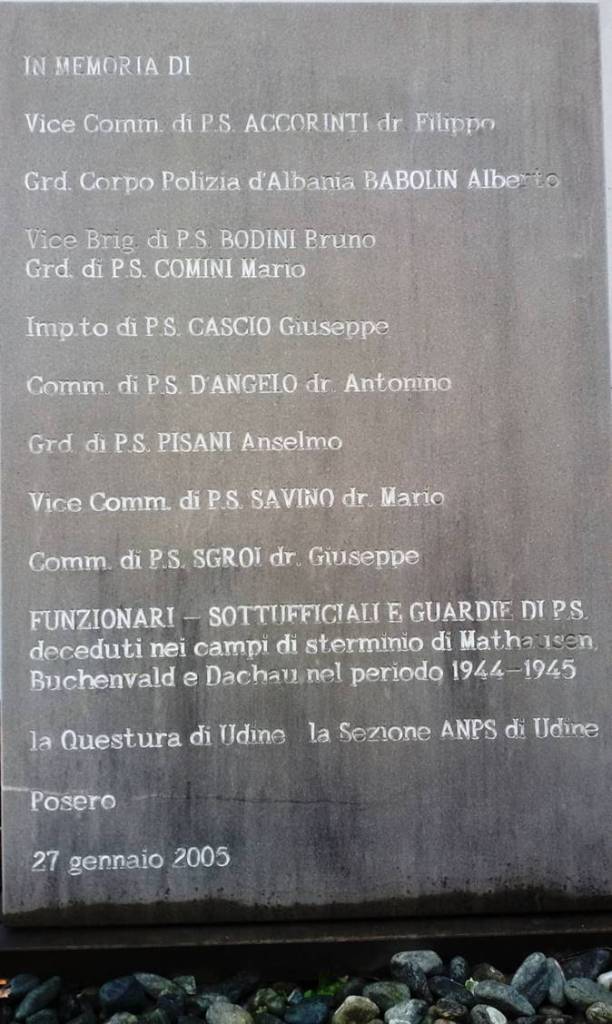Certi studiosi sostengono che nel Nord Italia e a Roma ci sia stata l’azione di agenti dell’Ozna, la polizia segreta iugoslava (vedi in Sitologia: Marenghi). Le spie di Tito non sono necessariamente tutte iugoslave; ad esempio, tra di loro ci può essere qualche stalinista italiano dal fervente spirito internazionalista, oltre che alla ricerca di protezione per le malefatte commesse sul suolo italico.
Da un rapporto segreto del Ministero dell’Interno italiano, del 1946, l’Ozna era “già riuscita ad infiltrare molti elementi nelle file dei cetnici [ex monarchici serbi], specie tra i profughi giuliani che si trovano a Roma nei campi profughi di Forte Aurelio e Cinecittà”. La stessa organizzazione segreta iugoslava, in base al citato rapporto, ha stretti contatti con i sovietici (vedi: Ozna, in Sitologia).
Le fucilazioni nel Nord Italia
A fine aprile 1945 ci sono decine di fucilazioni da parte di partigiani col fazzoletto rosso nelle prigioni di Pordenone e in quelle di Milano con l’accusa ai prigionieri di essere fascisti. A Trieste alla fine di maggio 1945, durante l’occupazione titina, durata dal 1° maggio al 12 giugno, si verifica un violento fatto strano. Un ordigno esplode a Villa Segre, dove sono acquartierati i partigiani garibaldini italiani, in teoria, filo-titini. Ci sono 5 vittime. È un increscioso incidente, oppure un attentato dell’Ozna contro i partigiani italiani “troppo poco comunisti e sciovinisti”? I partigiani garibaldini friulani sono giunti a Trieste il 20 maggio, come ha scritto Luciano Santin, al comando di Giovanni Padovan, commissario della Divisione Garibaldi e vice del raggruppamento “Friuli”, su 13 carri armati e autoblinde. Così sentenzia il quotidiano titino di Trieste «Il Nostro Avvenire» si tratta delle: “brigate italiane dell’Armata di Tito”. Questi partigiani hanno sì il fazzoletto rosso al collo, ma poco propensi a vedere sventolare solo la bandiera iugoslava nella sfilata in programma. Tito si aspetta un intervento di appoggio alle rivendicazioni slave su Trieste, Gorizia e parti del Friuli, ma Padovan “Vanni” al comizio nulla dice sulla nascente Settima Repubblica della Federativa di Jugoslavia, che nei piani titini avrebbe avuto per capitale Trst (Trieste) e arrivare fino al Tagliamento, compresa Videm (Udine). Ecco i retroscena del sanguinoso attentato di Villa Segre a Trieste.
Nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio del 1945 accadono altri gravi fatti di sangue in varie città del Nord Italia, che possono essere riconducibili all’Ozna. Squadre di partigiani comunisti attaccano le carceri col mitra per eliminare i detenuti, uccidendo pure i poliziotti. L’8 giugno si assiste all’attacco armato alle prigioni di Ferrara, che provoca 18 morti (vedi: Bruno Vespa), incluso Costantino Satta, comandante delle carceri giudiziarie, abbattuto a colpi di rivoltella.
Il 15 giugno successivo c’è l’assalto alla prigioni di Carpi, in provincia di Modena, che causa 14 cadaveri. Il bilancio complessivo tra Carpi e Ferrara è di 32 morti e circa 50 feriti, tra i quali ci sono alcuni fascisti, o presunti tali. Nella notte fra il 6 ed il 7 luglio 1945 c’è l’assalto partigiano al carcere di Schio, in provincia di Vicenza, che provoca la morte di 54 individui, comprese varie donne, reputati in blocco o in parte fascisti. Si può individuare un’unica strategia nei repulisti delle varie città italiane menzionate. Gli ordini probabilmente giungono dall’Est e sono condivisi, con spirito internazionalista, dai dirigenti locali del Pci succubi a Tito. Le citate carneficine sono collegabili per gli obiettivi generali cominformisti ad altri massacri, come l’eccidio di Porzùs (1945), in Friuli e la strage di Vergarolla, a Pola, in Istria (1946), pure ordita dall’Ozna. Di Vergarolla si sa il numero esatto dei morti identificati e sepolti, che sono 64, come segnato sulla lapide in San Giusto a Trieste. Nessun morto o ferito si registra fra i filo-iugoslavi a Vergarolla. Si sa con minore precisione il nome delle vittime non identificate e dei numerosi feriti, sui funerali, sul cordoglio e la solidarietà di polesi e di altri.
È il 18 agosto 1946. La guerra è finita da più di un anno ormai. Pola, in Istria, è un’enclave italiana amministrata dagli alleati, mentre gran parte della penisola istriana è stata occupata dalle forze militari titine. Anche Trieste coi suoi dintorni sta per diventare un’entità indipendente; è il Territorio Libero di Trieste, amministrato dagli alleati, fino al 1954, quando la città giuliana ripassa all’Italia. Sulla spiaggia di Vergarolla di Pola, affollata di bagnanti italiani, famigliole e bimbi, c’è chi assiste alle gare di nuoto della coppa Scarioni. Pochi polesani si preoccupano delle numerose mine e delle bombe di profondità ben disinnescate e ammucchiate lì vicino. È un deposito d’esplosivi a cielo aperto. Qualcuno va ad innescarne una, oppure piazza una bomba, per fare saltare “per simpatia” tutto il resto, come direbbe un artificiere. Chi è l’autore dell’efferato gesto? Lo si è scoperto nel 2008, dopo l’apertura degli archivi militari inglesi, come ha riportato «Il Gazzettino» del 18 agosto 2014. La responsabilità del misfatto è da attribuirsi all’Ozna, la polizia segreta di Tito, ma tale conclusione è stata contestata da parte slava. È a Fasana la sede dell’Ozna competente per le operazioni su Pola. Del resto, attentati dinamitardi titini si verificano, nel 1946, anche a Monfalcone e Trieste, come hanno documentato Paolo Radivo, nel 2016, oltre al «Messaggero Veneto» del 1946. “Tra la paura delle foibe e la strage di Vergarolla – dicono gli esuli riparati in Italia, come l’ingegnere Sergio Satti, esule a Udine – da Pola, la mia città, se ne andò il 90 per cento degli abitanti, tutti italiani”.
I temi riguardanti l’etica della Resistenza non sono oggetto di indagini solo di Gampaolo Pansa, che ha iniziato ad indagare sulle eliminazioni nel Triangolo rosso di Reggio Emilia con Il sangue dei vinti (2005), con La Grande bugia (2006) ed altro. Essi sono stati messi sul piatto della bilancia sin dal 1991 da Claudio Pavone, col suo Saggio storico sulla moralità nella Resistenza. Poi, per i ricercatori, è stato come un fiume in piena fino, appunto, al ruolo dell’Ozna negli eccidi dell’Italia del Nord.
Un passo indietro al 1943
Nelle città italiane, dopo l’8 settembre 1943, operano in armi contro i tedeschi i Gruppi di Azione Patriottica (Gap), appartenenti al Partito Comunista d’Italia. In Friuli c’è la Divisione Garibaldi Natisone e i partigiani garibaldini, dal fazzoletto rosso, sono di orientamento politico soprattutto comunista. Altri partigiani agiscono col fazzoletto verde e sono le Brigate Osoppo Friuli (BOF), di orientamento cattolico, monarchico e laico-socialista. Tutta la resistenza armata dovrebbe dipendere dal Comitato di Liberazione Nazionale (Cln), con esponenti politici della Democrazia Cristiana, Democrazia del Lavoro, del Partito d’Azione, del Partito Repubblicano, del Partito Socialista, del Partito Liberale e del Pci. Il Cln esige che sia fatto un processo prima di ammazzare qualcuno imprigionato con l’accusa di essere fascista, ma certe bande garibaldine filo-titine non seguono tale dettame, oppure intentano processi farsa, senza avvocato difensore o peggio ancora. L’occupazione titina di Trieste dal 1° maggio al 12 giugno 1945 provoca la deportazione di alcune migliaia di italiani o la loro uccisione ed eliminazione nelle foibe limitrofe. L’occupazione slava di Gorizia causa 1.048 deportati, tra i quali oltre 900 risultano scomparsi, eliminati nelle foibe, nelle cave, nelle fosse anticarro o nei campi di concentramento titini (i gulag di Tito), come in quello di Borovnica, tra Idria e Lubiana.
Vari gappisti al termine della guerra fuggono dal Friuli e dal Veneto nella Jugoslavia di Tito, che si annette l’Istria, Fiume e la Dalmazia, ove permangono forti presenze di italofoni, nonostante le violenze titine. Nel 1946 Mario Toffanin “Giacca”, lo stragista di Porzùs, fugge a Capodistria, evitando il carcere successivo alla condanna comminatagli nel 1951 al processo della Corte d’Assise di Lucca. Nell’Istria titina riesce a trovare tutta quell’accoglienza, che sia collegato all’Ozna? Il 7 febbraio 1945 avviene l’eccidio di Porzùs, in Comune di Faedis (UD); è un tragico ammazzamento fra partigiani. Quel giorno, infatti, alle malghe di Porzùs, diciassette partigiani (tra cui una donna, loro ex prigioniera) della Brigata Osoppo Friuli (BOF), sono fucilati da parte di un gruppo di partigiani, in prevalenza giovani gappisti di San Giovanni al Natisone (UD) e dintorni, comandati, o per meglio dire, terrorizzati da “Giacca”. Ciò segna il punto massimo delle tensioni fra partigiani garibaldini (pro-titini sloveni) e le BOF, che invece difendevano l’italianità del territorio, contro l’espansionismo nazionalista iugoslavo. È il signor B.V. a riportarmi in merito certe notizie, il 22 giugno 2015. Si riferiscono a suo padre Antonio (nome di fantasia, per riservatezza). Piuttosto che i ragazzi sotto leva finissero nella Organizzazione TODT (a lavorare per i nazisti), o nella Milizia Difesa Territoriale dei fascisti, o peggio, nelle Waffen SS italiane, i partigiani se li portano dietro in bosco. Il racconto fatto da Antonio, il requisito dai partigiani garibaldini, continua così: “Si sapeva che Giacca voleva fare pulizia, allora, si veve plui pôre di lui che dai todescs (si aveva più paura di lui che dei tedeschi)”. Giacca è il nome di battaglia di Mario Toffanin (Padova 1912 – Sesana, Slovenia 1999), il comandante partigiano che, su mandato del Comando del IX Korpus sloveno e dei dirigenti della Federazione del PCI di Udine, effettuò le uccisioni a Porzùs. Sono loro stessi, i partigiani dal fazzoletto rosso, a parlare di pulizia, un lessico tipico dell’Ozna.

Pure certi gappisti attivi tra Palmanova e Cervignano del Friuli, con l’appellativo di Diavoli Rossi se la svignano in Jugoslavia, primo fra tutti il loro caporione Gelindo Citossi, poi pure Norberto Sguazzin e un certo “Tom”, di Mortegliano; essi “emigrano in Jugoslavia”, come ha scritto Francesca Artico. Alcuni di tali partigiani fuggiti in Istria, come “Giacca”, Mario Abram (partigiano rosso triestino), Nerino Gobbo (noto infoibatore) e Giuseppe Krevatin se la prendono coi preti italiani, minacciandoli e picchiandoli a sangue, come ha riportato il «Giornale di Trieste» del 23 novembre 1951. I Diavoli Rossi, in base a quanto scritto da Elio Bartolini nel romanzo storico Il Ghebo, sono crudeli e con scarsa disciplina (pp. 12 e 34), pronti a rubare camion pieni di roba durante la guerra da portare oltre il Collio, in quella che sarà la Jugoslavia di Tito, per far bella figura coi titini, che li hanno ben posti sotto il Comando militare del IX Korpus. Bartolini, che aveva partecipato alla Resistenza nella zona, spiega che gli slavi vorrebbero annettersi, oltre all’Istria, Fiume e Dalmazia, anche un pezzo di Friuli, fino al Tagliamento (Bartolini, pp. 55, 65 e 102).
Tutti questi partigiani rossi veneti e friulani hanno un’accoglienza fraterna tra i titini che hanno invaso l’Istria, Fiume e Dalmazia, forse perché erano collegati all’Ozna. Li aspetta, tuttavia, una brutta sorpresa. Nel 1948 Tito rompe i patti con Stalin e i titini vogliono fare piazza pulita dei cominformisti, dei comunisti storici e degli stalinisti iugoslavi e italiani, annessi, ospitati, oppure organici dell’Ozna. Ci sono arresti ed uccisioni fra comunisti a Fiume e a Pola. Allora certi partigiani italiani scappati prima nel “paradiso di Tito”, poiché rei di crimini in Italia, svicolano in Cecoslovacchia, perché neanche Tito li vuole più tra i piedi. Quelli che Tito riesce a fare arrestare, li deporta all’Isola Calva, o Goli Otok (Gilas, p. 259); in quel gulag patiscono e muoiono di stenti, come in ogni campo di concentramento delle dittature. Alcuni dei fuggitivi italiani in Cecoslovacchia, forse per la coscienza sporca, cambiano addirittura nome, imbrogliando sui documenti.
La strage al carcere di Schio, luglio 1945
L’eccidio di Schio (VI) è un’operazione stragista perpetrata da 15 partigiani comunisti nella notte fra il 6 ed il 7 luglio 1945. A guerra finita, senza processo alcuno, muoiono nel carcere di Schio 54 detenuti (tra i quali 14 donne), poiché considerati in parte, forse o del tutto fascisti. Dopo i colpi di mitraglia qualcuno chiama i soccorsi. Un primo gruppo di barellieri viene respinto e minacciato e solo successivamente i feriti vengono trasportati all’ospedale. Anche qui medici ed infermieri, dediti alla cura dei sopravvissuti feriti, subiscono continue minacce dai partigiani garibaldini.
Al processo condotto dagli angloamericani, tenutosi a Vicenza nel settembre del 1945, dalle testimonianze degli imputati, ossia cinque partigiani appartenenti al battaglione di polizia ausiliaria “Ramina Bedin” e dai verbali da essi rilasciati e firmati, emergono le responsabilità di comando dell’operazione. In base alle testimonianze dei sottoposti i nomi dei comandanti della strage sono: Igino Piva, detto “Romero”, Nello Pegoraro, “Guido” o “Nello” e Ruggero Maltauro, “Attila”, come ha scritto nel 2020 Giorgio Marenghi, in Eccidio di Schio: le novità. Oltre alla Corte alleata si deve aggiungere l’azione della magistratura italiana che convoca un processo in Corte di Assise a Milano nel 1952. Un solo imputato è in catene; si tratta di Ruggero Maltauro, mentre altri sette si sono già rifugiati all’estero, alcuni di essi in Istria, annessa dal 1947 alla Jugoslavia di Tito.
Tra la fine della guerra e nel dopoguerra l’Ozna è presente in Italia del Nord. I suoi agenti si mimetizzano nei gruppi partigiani comunisti o nelle grandi città; osservano e prendono nota. Il loro obiettivo si lega allo sciovinismo-nazionalista di Tito, allargare l’area territoriale fino a superare Isonzo e Tagliamento, far pesare il ruolo militare dell’Esercito Popolare di Liberazione iugoslavo il più possibile quando sarà il momento di sedersi attorno ad un tavolo della pace, Alleati permettendo.
Quando scoppia la guerra civile spagnola Igino Piva è nelle Brigate Internazionali. Non si risparmia, il suo fisico resta segnato per sempre dalla battaglia di Guadalajara e da quella dell’Ebro. In Spagna conosce e stringe amicizia con una nota figura del comunismo, Vittorio Vidali, un personaggio scomodo, ma anche una testa politica con cui Piva fatica a confrontarsi. A luglio del 1944 Piva diventa comandante dei gruppi GAP nella provincia padovana. Questo impegno lo assorbe fino al dicembre del 1944 quando cambia nuovamente zona. Dal Veneto, su incarico dei vertici del PCI, giunge in Val D’Ossola per una missione partigiana sia militare che d’intelligence. Il caos del mese di aprile 1945 vede il Piva riparare a Milano dove svolge un compito decisamente stragista. Collabora, ma soprattutto dirige decine di fucilazioni con centinaia di morti, tra i prigionieri fascisti e i borghesi in odore di fascismo. Poi, finita la guerra, Piva torna in Veneto divenendo niente meno che dirigente dell’Ufficio investigativo della polizia ausiliaria partigiana, una pulita etichetta che nasconde solo la voglia di spremere notizie ai fascisti incarcerati. È in tal contesto che organizza il cruento assalto alle carceri di Schio del 6 luglio 1945.
La fuga in Istria
Poi, consapevole di ciò che ha comandato, Piva fugge nell’Istria da poco iugoslava. Non è solo un esilio, un approdo per un bisogno immediato di sottrarsi alla cattura degli angloamericani che lo vanno a cercare in Trentino. A Fasana, presso Pola, c’è la sede delle operazioni speciali che l’Ozna prepara per l’Alta Italia e per Roma. In quel mentre Piva incrocia sul suo cammino Vittorio Tinelli, un comunista friulano.
Il 1° agosto 1945 Igino Piva, assieme a Nello Pegoraro, è già a Capodistria e ha incontri con ufficiali del IX Korpus titino. Si noti che il territorio controllato dagli iugoslavi, aldilà del TLT, vede gli italiani in una situazione delicata. Italiano vuol dire esodo dall’Istria verso il TLT e Monfalcone, in Italia. Nel periodo in cui Piva inizia a muoversi in Istria avviene una ristrutturazione importante dei servizi segreti jugoslavi. Gli italiani sono malvisti dai titini. Come mai Piva riceve un’accoglienza coi fiocchi, e addirittura sale al comando, se non è collegato all’Ozna? Egli è accolto a braccia aperte, riverito, onorato e indirizzato a Pirano con il grado di comandante della Difesa Popolare della cittadina dell’Istria, nella Zona B del TLT, sotto controllo slavo. Anche gli altri seguaci vengono inglobati nella stessa struttura, ma per breve tempo. Igino Piva, oltre al Comando della Difesa Popolare di Pirano diventa anche membro del Comitato Distrettuale del Partito Comunista della Regione Giulia (Pcrg). È una costola del PCI che, basandosi dell’appoggio dell’intero Comintern, sosteneva che nel dopoguerra il problema dei confini avrebbe dovuto essere risolto a livello internazionale. Quindi il Pcrg è un partito nuovo che sostiene la fusione della comunità italiana con quella slava per aderire agli ordinamenti politici del comunismo di Tito.
Piva, nel 1945 sceglie la linea di Tito che si basa sull’espulsione graduale dell’elemento italiano, ma la sua gloria non dura molto. Il 3 dicembre 1946, viene espulso dal Pcrg “per aver sposato una donna non adatta, una ragazza piranese di ottima famiglia, dalla quale ebbe una figlia” (Cfr. Marenghi che cita M. Bonifacio, p. 57). Nel 1947 Piva lascia il comando della Difesa Popolare, si trova un lavoro e si prepara a una nuova fuga. Quando nel 1948 il Comintern bolla come “eretico nazionalista” Josip Broz Tito, Igino Piva, aiutato da Vittorio Vidali, comunista triestino, attraversa il confine iugoslavo, passa in Ungheria e poi in Cecoslovacchia. Dell’accordo con l’Ozna non gli rimangono neanche le briciole.
Conclusioni
I fatti dell’esodo giuliano dalmata e dell’uccisione nelle foibe dovevano restare nascosti perché c’era la Cortina di ferro, da Danzica a Trieste. Come disse Winston Churchill, nel marzo 1946, a separare l’Europa in due sfere politiche, una sovietica e l’altra angloamericana c’è la Cortina di ferro. In piena Guerra fredda e con le spie di tutto il mondo che ronzavano tra Trieste, Tarvisio e Gorizia non si doveva scomodare Tito, capo della Federativa Repubblica di Jugoslavia, che si stava staccando politicamente da Mosca e da Stalin, mentre gli agenti dell’Ozna gironzolavano nel Nord Italia e a Roma con i loro obiettivi.
La “Odeljenje za Zaštitu Naroda” (Ozna) è la sigla che significa: Dipartimento per la Sicurezza del Popolo. C’è una seconda versione che così spiega la sigla: “Oddelek za zaščito naroda”; letteralmente: Dipartimento per la protezione del popolo. Era parte dei servizi segreti militari iugoslavi e fu attiva dal 1944 fino al 1952. L’organizzazione titina, programmata da Tito e Milovan Gilas, era dotata di carceri proprie e attuava requisizioni, vessazioni ed addirittura ha programmato la pulizia etnica a Pola contro gli italiani. La pianificazione delle uccisioni di italiani in Istria, Fiume e Dalmazia per mano titina è stata documentata da Orietta Moscarda Oblak nel 2013, a pp. 57-58 di un suo saggio (vedi in Bibliografia). Agenti dei servizi segreti di Tito negli anni ‘50 si infiltrano perfino nei Centri raccolta profughi (CRP) sparsi in Nord Italia per carpire notizie sui rifugiati e per altre operazioni di stampo terroristico nelle città. Dal 1946 al 1991 la polizia segreta della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia diviene “Uprava državne bezbednosti/sigurnosti/varnosti” o Udba; letteralmente: “Amministrazione Sicurezza Statale”. Processato e incarcerato da Tito, dal 1954 al 1966, come dissidente lo stesso Milovan Gilas, nel 1991, riguardo all’Istria del 1945-‘46, dichiarò al giornalista Alvaro Ranzoni, del settimanale italiano «Panorama»: “Gli italiani erano la maggioranza solo nei centri abitati e non nei villaggi. Ma bisognava indurre gli italiani ad andare via, con pressioni di ogni tipo. Così fu fatto”. Gravi dichiarazioni mai smentite quelle di Gilas, che fu segretario del Komunisticna Partija Iugoslavije (Partito comunista iugoslavo); egli ammise inoltre in un suo noto memoriale che in Jugoslavia gli “arresti effettuati al di fuori della legge, come in tempo di guerra, continuavano a essere la pratica corrente” (Gilas, p. 12).
La Società di Studi Fiumani di Roma ha documentato nell’opera bilingue (italiano e croato) – Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni, pubblicata nel 2002 a cura di Amleto Ballarini, Mihael Sobolevski e presentata a Roma e a Zagabria, come andarono le cose dopo l’avvento della nuova dittatura comunista iugoslava. Sono oltre 580 le persone uccise a Fiume dalla polizia segreta dell’Ozna a guerra finita, senza umana giustizia. L’Ozna operò fino al 1952, assieme all’Udba, che poi prese le redini dei servizi segreti titini. La gente continua a chiamare le spie di Tito: quelli dell’Ozna.
Bibliografia e sitologia
- Francesca Artico, “Morto ‘Ferro’, partigiano dei Diavoli Rossi”, «Messaggero Veneto», Cronaca di Cervignano Latisana Bassa, 19 aprile 2020, p. 37.
- Amleto Ballarini, Mihael Sobolevski (a cura di / uredili), Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni (1939-1947) / Žrtve talijanske nacionalnosti u Rijeci i okolici (1939.-1947.), Roma, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi, 2002; anche nel web.
- Elio Bartolini, Il Ghebo, Udine, La Nuova Base, 1970.
- Mario Bonifacio, “La seconda resistenza del CLN italiano a Pirano d’Istria 1945-1946”, «Quaderni di Quale Storia» n. 15, Trieste, 2005.
- “La criminosa impresa organizzata dopo un invito al ‘popolo’ ad agire contro il clero”, «Giornale di Trieste», 23 novembre 1951.
- István Deák, Europe on Trial. The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution During World War II, Boulder, CO, Westview Press, 2015, traduzione ital. di Maria Luisa Bassi: Europa a processo. Collaborazionismo, resistenza e giustizia fra guerra e dopoguerra, Bologna, Il Mulino 2019.
- Milovan Gilas, Se la memoria non m’inganna… Ricordi di un uomo scomodo 1943-1962, (ediz. originale: Vlast, London, Naša Reč, 1983), Bologna, Il Mulino, 1987.
- Giorgio Marenghi, Eccidio di Schio: le novità, on line da giugno 2020.
- Orietta Moscarda Oblak, “La presa del potere in Istria e in Jugoslavia. Il ruolo dell’OZNA”, «Quaderni del Centro Ricerche Storiche Rovigno», vol. XXIV, 2013, pp. 29-61.
- O.Z.N.A.: La mano segreta di Tito, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Della P.S. – Divisione S.I.S., Roma, 19 novembre 1946, consulenza di Aldo Giannuli, Università di Milano; nel sito web storiaveneta.it
- Giampaolo Pansa, I gendarmi della memoria. Chi imprigiona la verità sulla guerra civile, Sperling & Kupfer, 2007.
- Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati-Boringhieri, 1991.
- Paolo Radivo, La strage di Vergarolla (18 agosto 1946) secondo i giornali giuliani dell’epoca e le acquisizioni successive, Libero Comune di Pola in esilio, «L’Arena di Pola», 2016.
- Alvaro Ranzoni, “Se interviene anche l’Islam”, «Panorama», 21 luglio 1991.
- Luciano Santin, “Quando i titini se la presero con il capo garibaldino Sciovinista italiano”, «Messaggero Veneto», 19 giugno 2020, p. 38.
- Elio Varutti, Massacro gappista del Ghebo, in Friuli e i poliziotti di Udine al lager, 1944, on line dal 21 aprile 2020.
- Bruno Vespa, Vincitori e vinti. Le stagioni dell’odio delle leggi razziali a Prodi a Berlusconi, Milano, Mondadori, 2005.
—
Messaggi dal web
Giuseppe Ritschl, di Torino, figlio di esuli che vive a Senigallia (AN), il 9 giugno 2020, nel gruppo Anvgd Arezzo di Facebook, ha scritto: “Mio padre mi raccontò che agli inizi degli anni ‘70 componenti dell’Ozna erano presenti nel posto di lavoro a Torino; li riconobbe perché erano compaesani al servizio degli Slavi.
Giorgio Hervato, lo stesso giorno, ha aggiunto: “Dai racconti di mio padre, erano peggio gli stessi paesani italiani dichiarati partecipanti dell’Ozna che gli stessi slavi; sempre dai racconti, la peggior specie erano i comunisti italiani di lingua slava passati alla parte di Tito”.
—
Servizio giornalistico, di ricerca e di Networking a cura di Tulia Hannah Tiervo, Sebastiano Pio Zucchiatti e E. Varutti. Copertina: La banda dei Diavoli rossi; archivio ANPI Udine. Fotografie da collezioni private e dall’archivio dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia (ANVGD), Comitato Provinciale di Udine, che ha la sua sede in Vicolo Sillio, 5 – 33100 Udine. Telefono e fax 0432.506203 – orario: da lunedì a venerdì ore 9,30-12,30. Presidente dell’ANVGD di Udine è Bruna Zuccolin.